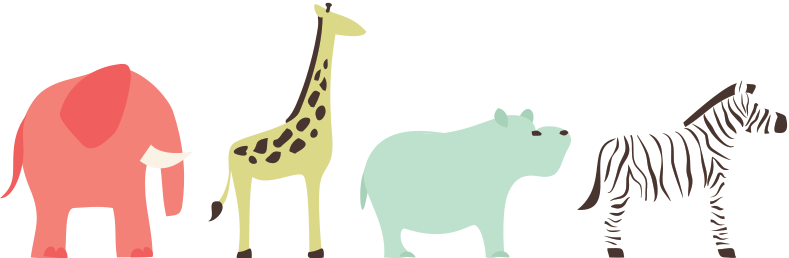(…Continua)
Con Rock Dog e Sing, seppur completamente diversi tra loro, gli autori entrano nel territorio ormai confortevole del talent show.

La prima pellicola, coproduzione cino-americana diretta da Ash Brannon e basato su una graphic novel di Zheng Jun Tibetan Dog, appartiene al filone dei romanzi di formazione applicati a personaggi animali antropomorfi, in cui l’avventura del protagonista ha il sapore di un percorso squisitamente individuale seppur mai individualista. Come nella migliore tradizione disneyana infatti ha un alter ego buffo, grottesco e ben conscio del suo ruolo di spalla nonostante gli eccessi superomistici. La tradizione antropomorfa dell’applicazione dell’animalità ai caratteri attribuisce tenacia e fedeltà al pastore tibetano, giovane e sognatore, capace di comporre melodie dalla facile presa e immerso quasi suo malgrado in un mondo di luci stroboscopiche e spiazzanti, una metropoli orientale ipermoderna in cui potremmo facilmente riconoscere Shangai, Honk Hong e anche tratti di Tokyo. L’amico produttore è invece un gatto, a suo modo “sognatore” ma con tratti di cinismo e opportunismo più accentuati. L’adolescente aspirante rock-star si contrappone al sogno di tranquillità e continuità portato avanti da suo padre, che come la specie suggerisce è un mandriano di pecore. Anche questa volta la versione italiana si affida a voci note nel doppiaggio e nella resa dei pezzi originali, pur arricchendosi nella colonna sonora non originale di brani non troppo inflazionati nel genere animazione. L’inclinazione “rock” del giovane Bodi si esprime forse maggiormente attraverso brani celebri dei Foo Fighters e persino dei Radiohead, più che nelle creazioni originali.
Con Sing di Garth Jennings, uscito anch’esso nel 2016 (per la Illumination), si abbandonano i luoghi esotici di Rock Dog, la pennellata cupa delle montagne tibetane contrapposta alla luminosità della grande città e si abbandona anche il rock in senso stretto. L’ambiente è più “usuale”, ma non per un film d’animazione: viene ritratta un’immensa Los Angeles, fatta di palme e viali alberati in zone di lusso ma anche di quartieri modesti, di sordidi anfratti e fascinosi teatri in decadenza. Ogni luogo mostrato è volto ad introdurre e ad esplicitare vizi, virtù e tratti genuini dei personaggi coinvolti in quello che ha l’ambizione di essere un film corale.

Il repertorio torna ad essere essenzialmente pop, senza eccessive punte di trash – qualcosa resta: si pensi all’ammiccante esibizione delle “conigliette” e a quanto la mancata traduzione giovi in fondo ad una maggiore fruibilità da parte del pubblico infantile. Dopo un’introduzione sui vari personaggi coinvolti e sull’idea che il protagonista trova per risollevarsi dalla bancarotta, il cuore del film sembra risiedere nelle numerose esibizioni dei protagonisti per il provino, tagliuzzate e montate freneticamente frustrando in modo sapiente l’eventuale affezione di chi guarda. Anche in questo caso la natura ferina risolleva le sorti del film costruendo una simulazione di casting che è un’alternativa gustosa a quelli originali. Infatti, se nel talent-reality di personaggi in carne ed ossa si ricerca spasmodicamente la risata mettendo all’indice i difetti degli “scrutinati”e facendo anche leva su una reale disabilità canora, qui le caratteristiche fisiche degli animali rincorrono la gag senza però risultare squalificanti nei confronti del loro pur manipolato desiderio di esibirsi: il bravo cantante giraffa viene allora “eliminato” solo per la fretta di Buster che non riesce a comunicare per via del suo lunghissimo collo, le rane si autosabotano per battibecchi emotivi, le veloci scoiattoline che parlano e comprendono solo il giapponese si dimostrano inaspettatamente tenaci.
Fuori dal contest i calamari danzanti, coreografi e insieme luminarie viventi dell’ambizioso progetto finale che regala momenti suggestivi e onirici alla pellicola, altrimenti trainata da una rappresentazione “terrena”.
Il koala Buster Moon è una figura che in parte potrebbe richiamare il gatto – produttore- musicista di Rock Dog ma più complessa, con un buon mix di cinismo e ingenuità. Lo domina un sogno d’infanzia dei più ricorrenti: onorare la memoria di suo padre riportando in auge il suo vecchio teatro.
Riempiono la scena i sospiri adolescenziali, declinati in varie accezioni: il gorilla Johnny è figlio di un malavitoso (e in molti hanno storto il naso per questa associazione) ma pensa solo a cantare, e sua è l’esibizione sulle note di Elton John; la timida elefantessa Meena possiede una voce angelica e cristallina che più volte le resta strozzata in gola, come vuole il più frequente dei cliché riguardo alla ragazza comune – leggi ; grassottella – che vuole “farcela”, supportata da una famiglia invadente e più che allargata che fa quasi traboccare lo schermo. E infine c’è Ash, l’istrice che canta in duo con un fidanzato presuntuoso che non viene scelto, rabbiosa e “riot girl” quanto basta per bilanciare la zuccherosità dei pezzi che vorrebbero affidarle, nel cui timbro arrochito si potrà riconoscere Scarlett Johansson (che ha pubblicato alcuni dischi all’apice della sua carriera da attrice). Il “talent” è però più variegato, e se l’impeto giovanile sembra trainante interessante è il tentativo di coinvolgere altre fasce d’età, di varia provenienza sociale e necessariamente etichettate anche dalla specie. La scrofa Rosita, con i suoi 25 chiassosi maialini, è una parodia efficace di un trito e asfissiante menage coniugale stereotipato ma ancora presente nelle grandi città e radicato in molte culture, in cui la parte femminile sopporta la routine, la fatica dei lavori domestici e soprattutto il silenzio assordante di un marito assente. Il suo numero con Gunther,maiale obeso ed effeminato, con la rivisitazione parziale delle liriche di un famoso pezzo di Taylor Swift, le permetterà di riappropriarsi di quella parte sopita di se stessa, delle sue pulsioni e della sua identità annullata dal non-sguardo degli altri. Il topo Mike è un sassofonista e cantante fallito, dalle suadenti movenze da crooner anni ’50 – la sua canzone finale è, ovviamente, il testamento musicale di sinatra My Way – la cui aggressività verbale tradisce i trascorsi di una vita da strada. La criminalità più o meno organizzata e gli equivoci finiranno per distruggere in parte i sogni di gloria di Moon.
Il finale vedrà ricombaciare tutti i pezzi del mosaico in modo più o meno scontato, fondendo in modo conciliante e vagamente confuso aspettative di adulti e bambini. Mirabolante, sfarzoso e più complesso di a quanto sembri, Sing sembra operare così la fusione tra i due mondi dell’intrattenimento, con la sua ricerca di una godibilità semplice ma non semplicistica, il suo gusto per le allusioni e i dopi sensi, non necessariamente di natura sessuale o “scadenti” in un umorismo becero pur facendo leva su istinti e reazioni ferine, avvicinandosi in tal senso alla multi-animalità di Zootropolis. Resta, in fondo, quel senso da sovraccarico di emozioni e di citazioni, difficili da amalgamare e astringenti abbastanza da non lasciare al film una traccia originale, un’anima indipendente e una nuova interpretazione del concetto di colonna sonora.