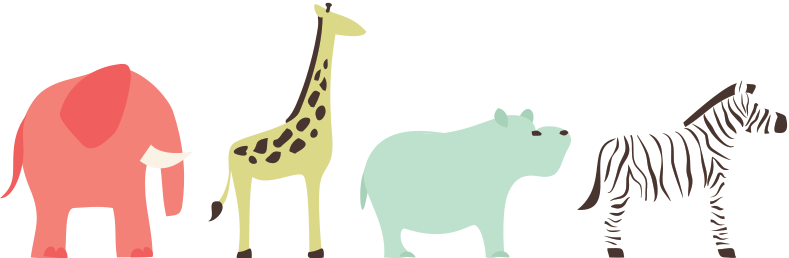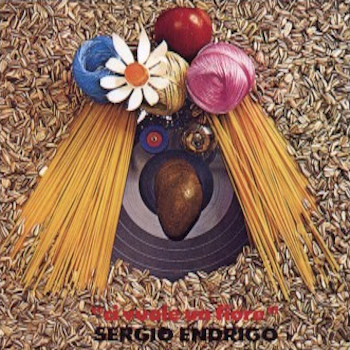La pubertà incontra la storia familiare attraverso rituali magici ed esplosive riflessioni

| Titolo originale | Turning Red |
|---|---|
| Lingua originale | inglese |
| Paese di produzione | Stati Uniti d’America |
| Anno | 2022 |
| Durata | 99 min |
| Genere | animazione, fantastico, commedia, avventura |
| Regia | Domee Shi |
| Sceneggiatura | Domee Shi, Julia Cho |
| Produttore | Lindsey Collins |
| Produttore esecutivo | Pete Docter |
| Casa di produzione | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures |
| Distribuzione | Disney+ |
| Musiche | Sceneggiatura |
In molti storcono il naso di fronte ai riadattamenti Pixar e Disney di questi ed altri decenni. La magia della fiaba trasfigurata, per necessità o per marketing, verrebbe spezzata dall’evidente linearità del protagonista e della sua mancata evoluzione rispetto ad un progetto di vita- Progetto che non mancava ad eroine ed eroi del passato millennio, pur nel tradimento adattativo. Chi era e chi sarà la Mulan, così diversa da quella della leggenda, o meglio: sarà chi è sempre stata o cambierà, come nei più classici coming of age. La Pixar, come spesso accade, non si affida alla fiaba né alla saudade per un tempo lontano mai realmente esistito ma dopo un rinnovato interesse nei confronti delle proprie produzioni si cala nella realtà del passato individuale di una dei suoi autori. Un passato non glorioso, affiancato ad una rievocazione storica recente da riscattare, ravvivandola però con l’ironia già radicata in molte pellicole. La regista sino canadese torna indietro di 20 anni, a quel 2002 in cui le preadolescenti grattavano goffamente la patina delle convenzioni, le abbracciavano e riemergevano dall’abisso con abiti sgargianti e improponibili. Si riappropria dell’estetica da polaroid e dell’ovattata era musicale delle boyband, segnale di allarme nel passaggio all’adolescenza piena e feticcio da cui discostarsi gradualmente di fronte all’imminente ascesa del primo, vero e carnale interesse amoroso. La protagonista Mei Lin si presenta con una struttura disegnata con linee morbide, un abbigliamento volutamente antiquato rispetto a quello delle sue coetanee – persino rispetto a quello delle sue amiche, come lei “outsider” – e un’energia emotiva incontenibile che esplode al contatto con le rigide tradizioni di famiglia. Si muove al ritmo sincopato delle occidentalissime sonorità R’n’B di fine anni ‘90 – inizio 2000 ma allo stesso tempo risente di quelle trasformazioni psico-fisiche stilizzate care, forse, all’immaginario di anime e manga. Stelline negli occhi, flussi ed effetti fumosi che arricciano, allungano, cancellano il naso e allo stesso tempo scavano nei terreni più scivolosi dell’imbarazzo, nell’egoismo insito nella necessità di autoaffermazione e nelle piccole meschinità quotidiane.

La storia di Meilin è soltanto sua, così personale e peculiare da tratteggiare con precisione un’età e la sua collocazione all’interno di un bizzarro e onirico rituale di famiglia. Il tenero ed enorme panda rosso in cui si trasforma rievoca, nel colore e nell’espressione, tuta una serie di rimandi scontati e più sottili, psicologici e storici. La rabbia e la seguente rassegnazione, non trovando pace, assumono le sembianze cartoonesche ed infiammate tanto vicine al piccolo personaggio di Inside Out, superandone la caratterizzazione. La deflagrazione e successiva riconciliazione passeranno allora per un’affastellamento peloso che comprime l’inquadratura, fattasi cupa. Il personaggio ha bisogno di crescere, ma non lo farà attraverso il tipico romanzo di formazione poiché cercherà di adattarsi al mondo ma, allo stesso tempo, di costruire per sé un angolo speciale e diverso da qualunque altro. La sottile carttiveria. I cedimenti e le altalene “ormonali” di una ragazza come le altre riescono allora a suggerire e a dipingere un essere umano del tutto originale, scontrandosi con il mondo alieno e allo stesso tempo conformista al suo interno rappresentato dalla madre.

Turning red racconta il cambiamento obbligato dell’adolescenza con toni apparentemente leggeri pur rivelando, a tratti, l’essenza turbolenta e fortemente drammatica dello stesso, suggerendo, senza alcun appesantimento didascalico, l’inusitata forza regressiva della repressione e la difficoltà della comunità di origine cinese nel difficile percorso ibrido tra “mantenimento” ed inclusione. Allo stesso tempo percorre una strada di disvelamento della psiche femminile in formazione, suggerendo con immagini giocose il flusso dei pensieri e l’affacciarsi simultaneo di sentimenti e descrivendo le contraddizioni dei primi veri legami tra ragazze. Con Red Domee-shi sembra sviluppare in forma narrativa e compiuta il piccolo e poetico corto “Bao”, in cui l’amore materno passava attraverso una bizzarra rivisitazione culinaria ed un inquietante istinto cannibalesco, simbolo della norma genitoriale che, incapace di autonormarsi, fagocita letteralmente i propri figli.